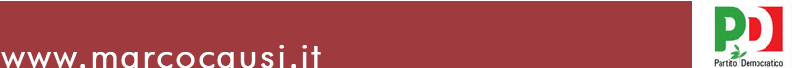Signor Presidente, chi mi ha preceduto ha correttamente introdotto l´esame dei due provvedimenti, confluiti in uno solo (mi riferisco sia al relatore, l´onorevole Conte, sia ad altri colleghi), inquadrandoli all´interno di un episodio di crisi finanziaria ed economica di livello internazionale che ha investito e investe il nostro Paese, insieme a tutti gli altri Paesi europei. Si tratta di un episodio di crisi finanziaria ed economica assolutamente al di fuori dei parametri normali delle crisi finanziarie ed economiche: un episodio di tipo sistemico, che certamente ha assunto, assume e assumerà caratteri davvero storici.
Signor Presidente, non voglio ripetere ciò che altri colleghi hanno affermato, ma, ricollegandomi a loro, vorrei che non dimenticassimo che quanto appare come epifenomeno, come una crisi di origine finanziaria, ha in realtà origini e radici fortemente legate a tendenze delle economie reali nazionali e del sistema internazionale degli ultimi anni. In realtà, è sempre stato così nei sistemi capitalistici dove le crisi emergono come crisi finanziarie, ma vi è sempre qualche fenomeno reale dal quale esse nascono.
I fenomeni reali, in realtà, hanno origine nel nuovo mondo che si è creato negli ultimi venticinque anni. Signor Presidente, voglio svolgere questa riflessione e condividerla con lei e con tutti i colleghi. Negli ultimi mesi si sono sprecati paragoni fra la situazione attuale del mondo e quella del 1929.
Vorrei proporvi, invece, di considerare quella attuale come una situazione in cui si chiude un ciclo di equilibrio economico e politico, cominciato in realtà nel 1989, cioè con la caduta del muro di Berlino, con la fine della guerra fredda e, quindi, dell´equilibrio contrapposto tra sistemi di libero mercato, da un lato, e sistemi di socialismo realizzato, dall´altro.
È lì, già dalla seconda metà degli anni Ottanta, che affondano le radici quattro forti squilibri reali, che oggi, anche tramite la crisi finanziaria, sono esplosi. In primo luogo, un permanente squilibrio negli Stati Uniti tra domanda interna e produzione. Di qui, la corsa dell´economia americana e statunitense, che è stata ovviamente anche facilitata dal nuovo equilibrio mondiale creatosi dopo la caduta del muro di Berlino, con una accumulazione costante di uno squilibrio della bilancia dei pagamenti, che è salito, di anno in anno, dagli 80 ai 200 miliardi di dollari l´anno.
Quindi, vi è stato un rilevante squilibrio della bilancia dei pagamenti negli Stati Uniti. Fino al 2001, poi, gli Stati Uniti avevano, soprattutto durante gli anni Novanta, riportato in equilibrio, addirittura in avanzo, il bilancio pubblico. Dal 2001 in poi, dopo l´11 settembre, per effetto anche degli eventi bellici susseguenti, negli Stati Uniti allo squilibrio di bilancia dei pagamenti si somma e si aggiunge uno squilibrio di finanza pubblica. Infatti, per effetto della decisione di quel Paese di affrontare la crisi del «dopo 11 settembre» utilizzando ampiamente strumenti di belligeranza, naturalmente, come sempre è accaduto nella storia in questi casi, anche il bilancio pubblico è andato in deficit.
Il secondo elemento di squilibrio è, invece, l´inverso. Questa corsa degli Stati Uniti in un nuovo equilibrio economico e politico del «post 1989» ha consentito uno spazio, che non c´era mai stato prima, per tutte le economie del mondo, che continuiamo a chiamare emergenti, ma che, in realtà, in alcuni casi importanti, sono ormai pienamente emerse.
Per più di vent´anni, la domanda americana ha trainato molto più di quella europea. Peraltro, vi è l´importante sviluppo asiatico e di tantissime altre economie, che ormai hanno raggiunto un reddito medio, con uno squilibrio finanziario. Infatti, le economie la cui bilancia dei pagamenti era in attivo, quelle asiatiche, oltre che quelle dei Paesi produttori di petrolio, hanno accumulato finanza prevalentemente denominata in dollari. A questo punto, il problema mondiale era come riportare quest´enorme quantità di finanza che affluiva ai Paesi in attivo (Paesi asiatici e produttori di petrolio) nei Paesi occidentali, soprattutto negli Stati Uniti.
È in tale contesto che si è determinato uno sviluppo dell´industria dei prodotti finanziari, soprattutto dell´industria anglosassone dei prodotti finanziari, che, con molta creatività e ingegnosità, ha inventato nuovi prodotti e li ha anche deregolamentati, come è stato ricordato, con una legge del 1999, che porta la firma di un deputato repubblicano, ma che fu vistata dall´allora Presidente democratico del Congresso americano. In questa sfida per l´innovazione finanziaria, i sistemi angloamericani esprimevano il loro bisogno di competitività nella capacità di produrre prodotti appetibili sul mercato della finanza, perché bisognava riallocare e far tornare in quei sistemi enormi quantità di finanza.
Un terzo elemento di squilibrio reale - non lo dobbiamo dimenticare - è il fatto che la crescita statunitense di questi venticinque anni non è stata, come troppo spesso tendiamo a pensare nella discussione politica, solo una crescita drogata dall´economia finanziaria. Non è così.
Dentro questo nuovo equilibrio gli Stati Uniti hanno fornito un contributo reale alla crescita mondiale, di proporzioni enormi. Abbiamo già citato il loro contributo alla crescita dell´economia dei Paesi emergenti e possiamo citare, ad esempio, un altro parametro: gli Stati Uniti, in questi venticinque anni, hanno assorbito popolazione migrante dal resto del mondo ad un tasso più che doppio rispetto all´Unione europea.
Sappiamo quanto siamo entrati in crisi nei nostri Paesi europei e nei nostri sistemi di regolazione sociale, istituzionale, anche politica, addirittura con partiti anti-immigrazione che cavalcano l´ondata della difficoltà sociopolitica e istituzionale. Bene, gli Stati Uniti hanno assorbito più del doppio della popolazione migrante.
Un quarto elemento di squilibrio, lo ha determinato - qui, però, voglio ricordare che i dati ci dicono che questo ultimo elemento è più caratterizzante per gli ultimi otto anni (quindi, non per gli anni Novanta, ma per il primo decennio del nuovo millennio) - una situazione in cui le politiche pubbliche non hanno più presidiato gli elementi di distribuzione del reddito e di coesione sociale.
Negli ultimi otto anni, negli Stati Uniti è aumentata enormemente la forbice tra aumento della produttività e aumento dei redditi da lavoro. Le politiche pubbliche ispirate ad un eccesso di liberismo e ad una forte concentrazione sull´industria militare e sulle spese militari hanno dimenticato colpevolmente gli interventi di coesione sociale e di lotta alla povertà; viceversa, si è fatto credere a tutti, compresi i migranti di ultima generazione, che in quel Paese tutto fosse possibile, perché il credito era molto facile.
Anche la crisi dei mutui in quel Paese nasce da un´accessibilità al bene casa molto facile. Un´accessibilità predicata non tramite interventi di social housing, come succede nei migliori sistemi europei (soprattutto quelli del nord, perché in Italia sul social housing siamo ancora in grave ritardo) ma con una politica di facile accesso al credito, che poi, a un certo punto, ha determinato una bolla speculativa e finanziaria e che oggi vede «incagliate» soprattutto le famiglie a reddito basso o medio-basso, comprese molte famiglie di migranti di ultima e penultima generazione.
Credo che nessuno abbia ancora ben capito come uscire da questa crisi. Siamo all´interno di un percorso di approssimazione culturale e politica dentro il quale - ha ragione chi ha parlato prima di me, l´onorevole Alberto Fluvi - dobbiamo anche fare ricorso al massimo di intelligenza e al minimo di strumentalizzazione politica, ma certamente il mondo è alla ricerca di un nuovo equilibrio dopo la caduta del muro di Berlino.
Si inizia a capire che questo nuovo equilibrio certamente avrà almeno sei caratteristiche. Le enuncio molto velocemente: anzitutto, dovrà essere un equilibrio molto più multilaterale e molto meno unipolare di quello di questi ultimi 25 anni. In secondo luogo, dovrà essere un equilibrio in cui riacquistino ruolo le istituzioni di coordinamento internazionale, sia quelle di area regionale, come, ad esempio, l´Unione europea e altre unioni simili di livello regionale, sia quelle di coordinamento più propriamente internazionale.
In terzo luogo, questo nuovo ruolo delle istituzioni internazionali dovrà essere ottenuto con una riforma radicale di queste stesse istituzioni. Al riguardo, voglio ricordare che sul terreno delle proposte per la riforma delle istituzioni internazionali il Paese Italia ha fornito contributi molto importanti.
Voglio qui ricordare che la prima proposta moderna di riforma del Fondo monetario internazionale nasce dall´Interim Commettee del Fondo monetario internazionale, presieduto nel 1998 dall´allora Ministro del Tesoro del Governo italiano Carlo Azeglio Ciampi.
Da lì nascono le proposte che portano poi alla creazione del Financial Stability Forum ed è ancora da lì che nascono alcune proposte che oggi di nuovo si affacciano come, per esempio, quelle tendenti a dare un ruolo più forte all´International Monetary and Financial Committee del Fondo monetario internazionale, che invece, purtroppo, per la mancata attuazione delle linee di riforma proposte dall´Interim Committee presieduto da Ciampi nel 1998, ha perso negli ultimi anni presa ed è caduto del tutto in una logica, direi, meramente, e qualche volta biecamente, intergovernativa, con pesi dei diversi Governi che non riflettono più l´effettivo peso dei diversi sistemi socioeconomici all´interno dell´equilibrio mondiale.
In quarto luogo, occorre un mutamento radicale di tipo culturale. Diciamolo: dovremo superare quello che, nel corso di questi venti anni, si è chiamato il Washington consensus, e quindi politiche improntate ad un forte iperliberismo, che, ad esempio, sono state anche molto dannose in tutti i processi di aggiustamento imposti dalle istituzioni internazionali, come il Fondo monetario, ai Paesi in via di sviluppo.
In quinto luogo, dovremo costruire gli elementi di una nuova governance mondiale. Abbiamo già detto del Fondo monetario internazionale, ma non vorrei che ci dimenticassimo che elementi di governance mondiale dobbiamo trovarli anche ad esempio attraverso la predisposizione, il monitoraggio e il controllo delle condizioni di lavoro in tutti i Paesi del mondo tramite un rafforzamento in questa direzione del ruolo dell´Organizzazione internazionale del lavoro. Infatti, è anche tramite il miglioramento delle condizioni di lavoro che si ottiene, da un lato un miglioramento della domanda interna di tutti i Paesi, dall´altro la riduzione dei fenomeni di concorrenza sleale.
In sesto luogo, sono necessari la conclusione dei round mondiali relativi al WTO e la riabilitazione e il pieno perseguimento degli obiettivi del Millennium round sulla lotta alla povertà, confermati da un recente vertice internazionale.
Insomma, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se dovessi consigliare una lettura in questo momento, consiglierei quella di un libro di Stiglitz: non quello che tutti conosciamo, cioè La globalizzazione e i suoi oppositori, uscito nel 2002 dopo che Stiglitz aveva, in modo critico, abbandonato il suo ruolo di capo economista della Banca mondiale, bensì un libro di Stiglitz pubblicato nel 1990, un anno dopo la caduta del muro di Berlino, che non è stato peraltro tradotto in italiano e che si intitola: Whither Socialism?. La parola «whither» in inglese significa «al posto di»: in questo libro Stiglitz, nel 1990, si interroga: come funzioneremo, adesso che non c´è più il socialismo? Come funzionerà adesso il modello capitalistico occidentale in assenza di un contrappeso nei sistemi socialisti?
In sostanza, in quel libro Stiglitz con vent´anni d´anticipo capì che il mondo unilaterale di cui allora si gettavano le fondamenta mancava di contrappesi, contrappesi che nella tradizione di pensiero di Stiglitz, quindi nella tradizione di pensiero democratica e keynesiana, vanno essenzialmente ricostruiti nel ruolo dello Stato, nel ruolo dello Stato come regolatore, come presidio dell´uguaglianza e della coesione sociale, e come presidio dell´equilibrio economico.
Mi sto forse dilungando troppo, e proseguirò quindi il mio intervento molto più velocemente. Se davvero oggi volessimo chiamare in causa Keynes, come ha fatto l´onorevole Ventucci prima di me, per cercare di capire cosa sta succedendo nel mondo di oggi, dovremmo stare molto attenti, perché dovremmo ricordarci che la lezione di Keynes non è quella sulla spesa pubblica facile: questo è un keynesismo «accattone». La vera lezione di Keynes è sul ruolo dello Stato, e in generale delle politiche economiche, nel garantire che lo stato delle aspettative dell´economia sia positivo, e da questo punto di vista Keynes vedeva un ruolo molto importante per la politica monetaria piuttosto che per la politica fiscale. La politica fiscale doveva, secondo Keynes, intervenire soprattutto in momenti congiunturalmente difficili, momenti di crisi, ma dal punto di vista permanente il ruolo principale dello Stato era quello di generare positive aspettative.
Se volessimo chiederci come possono oggi i Governi nazionali, non soltanto i singoli Governi nazionali, ma tutti i Governi nazionali, ingenerare migliori aspettative al fine di velocizzare l´uscita dalla crisi, sicuramente dovremmo dire con Keynes: in primo luogo, in questo momento con tutta evidenza le politiche monetarie non sono sufficienti. Soprattutto in Europa, il livello dei tassi interbancari continua a non scendere nonostante politiche monetarie fortemente espansive, nonostante i recenti interventi, forse insufficienti, della Banca centrale europea sui tassi di interesse, e quindi è inevitabile che politiche fiscali espansive scendano in campo accanto alle politiche monetarie espansive.
In secondo luogo, tra le distorsioni originatesi nell´economia internazionale soprattutto durante gli ultimi otto anni, spicca quella collegata al fatto che i tassi di rendimento e i profitti attesi e voluti dagli investitori erano troppo elevati rispetto alle effettive condizioni strutturali dell´economia. Dovremmo ricordare, insieme a Keynes, che anche la distribuzione dei redditi ha un ruolo nella stabilità macroeconomica e che la distribuzione dei redditi prodottasi in questi anni è avvenuta in modo molto, troppo iniquo, sia negli Stati Uniti sia nei nostri Paesi europei. Quindi, politiche fiscali e redistributive.
I provvedimenti che oggi cominciamo a discutere sono, da questo punto di vista, insufficienti. Lo ha detto il collega Alberto Fluvi prima di me, questi due provvedimenti (due decreti-legge adesso unificati) hanno avuto un ruolo importante ed essenziale nel momento stesso in cui sono stati emanati perché hanno lanciato il segnale che anche in Italia, così come negli altri Paesi europei, lo Stato tutela il risparmio. Hanno quindi avuto un ruolo essenziale e positivo, che noi condividiamo, per allontanare il sistema creditizio e finanziario nazionale dalle potenziali crisi di fiducia dei risparmiatori, crisi che rischiavano, in una certa di fase, una quarantina di giorni fa, di potersi diffondere. Quanto agli altri due problemi che abbiamo di fronte - come ricostruire un intervento credibile dello Stato nelle nuove condizioni e come garantire che la recessione dell´economia reale (che non sta arrivando, ma è già arrivata nel nostro sistema e in quelli europei) non duri troppo -, ebbene, su questi due versanti, purtroppo, questi due provvedimenti sono insufficienti.
L´impatto reale della crisi, signor Presidente e cari colleghi, è già arrivato, ed è già arrivato in Italia in misura superiore a quanto avvenga negli altri Paesi europei. Le ultime stime dicono che l´Italia sarà l´unico Paese ad avere nel 2008 una crescita negativa: meno 0,3. La Germania è ancora
ampiamente sopra il più 1; la Francia è ancora stabilmente sopra il più 1, seppure in decrescita rispetto all´anno scorso; la Spagna è sul più 0,70, più 0,8, seppur in decrescita rispetto allo scorso anno. L´Italia sarà l´unico Paese ad avere il segno meno già nel 2008.
Molti sostengono la tesi che questo sia solo il frutto dei nostri problemi strutturali, ma io non lo credo. Ritengo che certamente i problemi strutturali abbiano avuto un ruolo, ma credo che nel determinare la recessione cui va incontro l´Italia nel 2008 giochino anche altri due elementi. Il primo consiste paradossalmente nella stretta creditizia, perché gli istituti bancari del nostro Paese, dato che stavano meglio degli altri, non hanno dovuto far ricorso all´intervento di ultima istanza dello Stato, così come non hanno fatto ricorso, in questi quaranta giorni, agli strumenti forniti dai due decreti che da oggi esaminiamo in Aula. Non avendo dovuto farvi ricorso, hanno cercato e stanno cercando di migliorare i loro coefficienti patrimoniali - come diceva l´onorevole Alberto Fluvi prima di me - restringendo il numeratore piuttosto che aumentando il denominatore, e quindi restringendo il credito. Hanno trasmesso quindi, tramite la restrizione del credito, una tendenza recessiva in Italia molto più velocemente e molto più automaticamente di quanto non sia avvenuto e stia avvenendo in altri Paesi europei. Si tratta di un paradosso: siamo meno coinvolti nella crisi finanziaria, ma il meccanismo di trasmissione della crisi finanziaria all´economia reale qui da noi sembra che stia funzionando molto più velocemente.
Il secondo motivo, signor Presidente, è che - dobbiamo dircelo - il Governo ha sbagliato il tono congiunturale della politica economica proprio in questi mesi. Ci rendiamo conto oggi che non ha avuto molto senso, ad esempio, restituire circa due miliardi e mezzo di ICI sulla prima casa alle sole famiglie abbienti, alle sole famiglie che non erano già state beneficiate dai precedenti provvedimenti del Governo, alle sole famiglie che hanno più di una casa, tramite il meccanismo delle unità immobiliari assimilate.
Ci rendiamo conto, quindi, che noi dobbiamo affrontare oggi non soltanto il tema della crisi finanziaria, ma anche quello del sostegno all´economia reale e di una politica reflattiva che in qualche modo cambi il segno delle politiche economiche degli ultimi sei mesi.
Su questo, il Governo e la maggioranza sanno che il Partito Democratico ha proposto una serie di emendamenti a questi provvedimenti che non hanno un intento né ostruzionistico né dilatorio, ma fortemente costruttivo. Si tratta di emendamenti e proposte che vanno dall´economia reale a quella finanziaria; l´onorevole Alberto Fluvi, prima di me, ha iniziato a illustrarli. Ne voglio soltanto ricordare uno tra i tanti: riteniamo che in qualsiasi forma lo Stato intervenga a migliorare i coefficienti patrimoniali degli istituti bancari (tramite azioni, obbligazioni, ma anche nelle forme più soft, ovvero soltanto tramite estensioni di garanzie o meccanismi di swap tra titoli pubblici e titoli di istituti bancari, come previsto, tra l´altro, dal decreto-legge n. 157 del 2008) sia necessario che lo Stato stesso si garantisca, e garantisca ai cittadini e al sistema delle imprese, che questi aiuti non si fermino al bilancio delle banche, ma vengano traslati, trasmessi dal bilancio delle banche a quello delle famiglie e delle imprese. Secondo noi, quindi, alle banche aiutate vanno poste alcune condizioni.
È necessaria una condizionalità dell´aiuto - chiamiamolo come vogliamo: adesione delle banche ad un codice di comportamento, sottoscrizione da parte delle banche di un piano di stabilizzazione che contenga alcuni paletti e vincoli; il problema non è il nome -; il miglioramento dei coefficienti patrimoniali garantito attraverso l´intervento dello Stato in qualsiasi forma, deve permettere alle banche a loro volta di abbassare, in primo luogo, i tassi variabili a cui sono agganciati i pagamenti di mutui per l´acquisto della prima casa. Vi sono molte decine di migliaia di famiglie che fanno fatica a pagare i mutui per la prima casa ai tassi variabili collegati all´Euribor, che, nonostante tutti gli interventi, non si è adeguato, in questi mesi, al tasso di rendimento interbancario garantito dalla BCE. Dal momento che le banche italiane potranno rifinanziare a un tasso più basso, dobbiamo garantire che il percorso di tendenziale avvicinamento del tasso variabile dei mutui al tasso di rifinanziamento della BCE sia abbastanza veloce.
In secondo luogo, le banche si devono impegnare a non escutere le proprietà delle famiglie in difficoltà sulle prime case gravate da ipoteche. Non possiamo aiutare le banche e contemporaneamente vedere famiglie in difficoltà sfrattate dalle banche stesse. Le banche dovranno aderire a degli schemi, insieme ovviamente agli enti pubblici, che permettano alla famiglie che sono insolventi di continuare ad abitare in qualità di coinquilini o di comproprietari le unità abitative che non possono più pagarsi.
In terzo luogo, gli aiuti dello Stato devono essere trasferiti alle piccole e medie imprese, impegnando gli istituti bancari, in qualsiasi modo aiutati, a trasferire a vantaggio delle piccole e medie imprese la loro capacità di credito, mantenendo inalterato il trend storico dei flussi di credito erogati a questo importante comparto del sistema produttivo italiano.
Infine, riteniamo anche che tra le procedure di condizionalità, da discutere e da contrattare con le banche in cambio dell´aiuto pubblico, occorra inserire una modifica dei sistemi retributivi del management bancario e che si escluda almeno per un anno - questo è il sistema delle condizioni che il Governo della Gran Bretagna ha utilizzato nei confronti degli istituti bancari soccorsi - la corresponsione dei premi e dei bonus al top management, che si riveda poi il complessivo schema di incentivazione dei manager, ancorandolo non più a obiettivi di breve termine, ma a parametri di lungo periodo.
Occorre, infine, rispondere, nella discussione in Aula, a tutti i pareri emanati dalle diverse Commissioni parlamentari che si sono espresse sul provvedimento; mi riferisco, quindi, a pareri votati anche dalla maggioranza. Vi è un lungo elenco di pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva che suggeriscono una serie di miglioramenti. Noi, come Partito Democratico, nei nostri emendamenti facciamo nostre tutte queste proposte che sono state condivise dalla maggioranza in sede di I Commissione, di X Commissione, e anche di Comitato per la legislazione.
Se la maggioranza e il Governo riterranno che non è questo il decreto che può fare da veicolo a questi miglioramenti, vogliamo però dire che quest´Aula deve compiere un lavoro per lo meno di sollecitazione nei confronti del Governo affinché nel prossimo decreto, sia esso il decreto sullo sviluppo, sia esso il secondo decreto sulle banche, tutti questi miglioramenti proposti dalle Commissioni parlamentari, con il parere favorevole dell´intero Parlamento (maggioranza e minoranza), possano essere inseriti.
La crisi in cui siamo - non la crisi che arriverà - sarà lunga, e io credo che non dobbiamo illuderci, la classe dirigente del Paese non può illudersi. Siamo entrati in una crisi lunga, difficile, potenzialmente molto complicata, anche alla luce del fatto che è una crisi inedita, dal punto di vista dei suoi riferimenti internazionali. Il mio gruppo, il Partito Democratico, è profondamente convinto che nel riaggiustamento dell´equilibrio economico mondiale - che poco fa ho cercato di tratteggiare - un ruolo molto importante lo avranno le nuove politiche che potranno essere messe in campo dalla nuova amministrazione statunitense. Dobbiamo riconoscere che l´elettorato americano, nel dare un mandato politico così forte ad una nuova amministrazione, ha anche lanciato il segnale della speranza e lanciato il segnale di una scelta di modifiche dell´impianto politico su cui si è retto il mondo in questi anni.
Riteniamo però che l´Unione europea, e l´Europa nel suo complesso, non possa lasciare da sola la nuova amministrazione statunitense. L´Unione europea dovrà fare la sua parte anche per aiutare la nuova amministrazione statunitense in un processo di riaggiustamento che in quel Paese rischia di essere molto lungo e doloroso. Quindi riteniamo che da questo punto di visto l´Italia all´interno dell´Unione europea debba giocare un ruolo importante nel proporre nuove politiche, nel reflazionare la domanda interna europea, nel contribuire allo svolgimento del suo ruolo di grande area economica monetaria e politica, per aiutare Stati Uniti, da un lato, e Paesi asiatici, dall´altro, in un processo di stabilizzazione economica che rischia di essere lungo e doloroso.
Prima o poi anche i nostri partner ci chiederanno: l´Italia che cosa fa? L´Italia è un Paese esportatore - non ce lo dimentichiamo - e se la Cina avvia un programma di 500 miliardi di euro e gli Stati Uniti di 700, e se la Germania aiuta le sue imprese e la Francia fa lo stesso, le imprese esportatrici italiane ne beneficeranno, quindi prima o poi anche i nostri partner ci chiederanno: voi cosa fate? Qual è il vostro contributo? Noi riteniamo che il nostro contributo debba essere una manovra molto urgente a sostegno del potere di acquisto delle famiglie, degli ammortizzatori sociali, e del credito alle piccole e medie imprese (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).